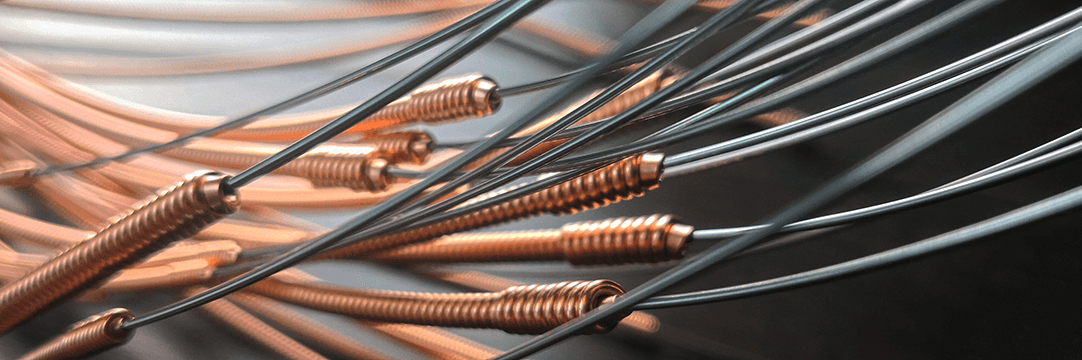L’evoluzione musicale che sostituì il clavicembalo
Scopri come l’opera e l’evoluzione della tecnica vocale portarono alla nascita del pianoforte, sostituendo il clavicembalo e rivoluzionando la musica occidentale dal XVI al XVIII secolo.

Fino al XVIII secolo, la musica occidentale attraversò una trasformazione profonda che preannunciava il declino del clavicembalo, uno strumento che aveva dominato per oltre tre secoli. L’arrivo del pianoforte, con la sua capacità espressiva dinamica, segnò una svolta inevitabile nella storia della musica.
Alla fine del XVI secolo, in Italia, un gruppo di intellettuali, composto da musicisti e letterati, formò una cerchia chiamata Camerata (dal termine italiano che significa "compagnia di amici"). Il loro obiettivo era ambizioso: riportare in vita la drammaticità e la potenza espressiva del teatro dell’antica Grecia. Da questo movimento nacque una nuova forma musicale, destinata a cambiare il volto della musica occidentale: l’opera.
I membri della Camerata rigettarono la complessità polifonica della musica rinascimentale, dove molte melodie si intrecciavano in una rete sofisticata, e crearono invece uno stile musicale in cui la melodia principale era accompagnata da accordi (una tecnica chiamata "recitativo"). Questo nuovo approccio permetteva alla voce di risaltare, esprimendo emozioni con maggior forza e chiarezza.
Le prime opere liriche della storia, come “Dafne” e “Euridice”, furono esempi concreti di questo cambiamento epocale. La musica vocale dell’opera, così ricca di emozioni e sfumature umane – gioia, dolore, rabbia, amore – risultava rivoluzionaria per l’epoca. In confronto, la musica sacra, con il suo tono astratto e austero, cominciò a sembrare distante e antiquata.
Con l’opera, anche la tecnica vocale si arricchì notevolmente: crescendo, decrescendo, trilli, vibrati, accenti dinamici, fino a includere espressioni estreme come il respiro affannoso o il pianto sommesso. Questa nuova sensibilità richiese strumenti musicali capaci di rispondere a simili esigenze espressive, e il clavicembalo – pur brillante nel suono – cominciò a mostrare i suoi limiti.
Il clavicembalo visse la sua epoca d’oro sotto il regno dei re francesi, con compositori come François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Domenico Scarlatti, che ne esplorarono appieno le possibilità. Tuttavia, anche in quel periodo, i gusti musicali stavano già cambiando.
J.S. Bach fu maestro nel fondere vecchio e nuovo stile, ma la sua musica, oggi considerata il vertice del Barocco, era vista ai suoi tempi come superata. Morì nel 1750, anno simbolico che segna il passaggio definitivo tra due epoche musicali: il trionfo della monodia accompagnata e l’abbandono della polifonia.
Lo stesso Couperin, nel 1713, scriveva nella prefazione alla sua raccolta di pezzi per clavicembalo:
“Il clavicembalo è uno strumento straordinario per ampiezza di estensione e brillantezza del timbro. Tuttavia, ha un limite insormontabile: non può produrre variazioni di intensità del suono. Se mai qualcuno riuscisse a donare a questo strumento l’espressività di cui ha bisogno, gli sarei profondamente grato.”
Ignorava, però, che a Firenze, Bartolomeo Cristofori aveva già inventato un nuovo strumento: il pianoforte ("pianoforte e forte" per la sua capacità di suonare sia piano che forte).
Inizialmente, il pianoforte non superava il clavicembalo per popolarità o raffinatezza. Tuttavia, nel corso della metà del Settecento, si rivelò lo strumento ideale per accompagnare la voce umana e le nuove esigenze espressive degli strumenti orchestrali. A differenza del clavicembalo, il pianoforte poteva variare l’intensità del suono, introducendo così crescendo, diminuendo, accenti e sfumature dinamiche. Questo lo rese irresistibile per i compositori e lo portò, inevitabilmente, a sostituire il clavicembalo, decretandone la scomparsa.